|
Il mito di
Giambattista Vico
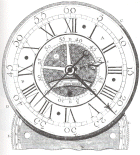
Vico è
uno degli uomini più curiosi della storia della letteratura e della filosofia.
E' senza paragone più citato
e ammirato che letto; di solito ci si limita alle parti sentenziose, come le
famose "degnità" (che sarebbe la traduzione etimologica di assioma), vivide e
pregnanti nel groviglio della più stramba delle prose (cosa che può dare
soggezione). Anche i contemporanei lessero e apprezzarono poco quei Principi
di scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni... che pubblicò
a sue spese nel 1725 e uscì definitiva nel '44; libro oscuro che provocherà una
passeggera curiosità da parte dei romantici tedeschi.
Foscolo inventò una formula suggestiva: "il filosofo della storia",
complementare al ricercatore, Muratori. La teoria dei "corsi e ricorsi",
applicabile a tutto, è entrata nel linguaggio comune (è perciò bene vederla
concretamente). Nessuno osò mai ridurne il mito, e Croce lo consacrò alla gloria
avvicinandolo a sé: sarebbe stato, in quel secolo scientifico e prosaico, lo
scopritore della "fantasia" - "la matta di casa", diceva Malebranche - e il
rivelatore dell'autonomia di questa facoltà creatrice.
I grecisti, in particolare i
giovanissimi, lo rispettano anche come iniziatore della "questione omerica",
così seria per chi non ha ancora letto Omero nell'originale o almeno nella sua
incomparabile poesia; ma è una calunnia, l'inesauribile "questione" è posteriore
ed è di natura prettamente filologica.
Le "pruove filologiche per la discoverta del vero Omero" non valgono più di
quelle filosofiche, ma sono più precise e perciò molto più insopportabili:
possono provocare per il Vico un vero risentimento. E invece è così facile
volergli bene, andargli vicino, leggere con semplicità, alla fine con
divertimento, la sua buffa prosa.
E' la rivelazione di un uomo.
Sappiamo molto di lui perché
si raccontò in un' Autobiografia in terza persona, scritta col suo solito
linguaggio bislacco, ma non senza maestà. Tacque solo delle cose meno degne d'un
grande, i mediocri successi, l'incomprensione per le sue scoperte, la povertà
che lo afflisse, per quanto professore della Regia Università di Napoli: ma lo
stipendio era scarso e aveva otto figli, uno dei quali un vero scavezzacollo, e
una moglie analfabeta così inetta che il filosofo doveva supplirla nelle sue
competenze donnesche. Arrotondava con lezioni private. In compenso, nell’Autobiografia,
si tolse due anni.

Era
nato nel 1668 a Napoli. A sette anni cadde battendo il capo e il medico previde,
se fosse sopravvissuto, una menomazione mentale; invece gli restò solo quel
caratteraccio che s'addice agli "uomini ingegnosi e profondi". Fu, racconta,
precocissimo, ma di salute fragile; per questo fece per nove anni, quelli
formativi, il precettore in una località solitaria del Cilento dove c'era una
biblioteca. Fu probabilmente fondamentale questa formazione di letture avide e
solitarie. Libri preziosi, lacune ignote. S'appassionò degli autori latini e
della maggiore poesia toscana.
Nell' Arte poetica di Orazio lesse che il poeta dev'essere prima di tutto
dotato di sapientia, giudizio che prese molto sul serio, e si dedicò alla
filosofia, quella che la biblioteca gli consentiva. S'innamorò di Platone. Per
tutta la vita, i suoi tre classici furono Platone, Tacito e Bacone. Non si
accordano molto, in verità; ma Tacito era secondo lui "mente metafisica
incomparabile", l'interprete dell'uomo eterno. Detestò sempre "monsignor Delle
Carte", cioè Cartesio, troppo limpido e troppo famoso. Avrebbe voluto sapere
quali sono queste famose "idee chiare e distinte"; ma la sua avversione riposava
su una vera incompatibilità di carattere.
Non sentiva dubbi gnoseologici; aveva la certezza del buon credente, all'antica,
perché anche "i pensieri del Pascale (sic) sono pur lumi sparsi". Non
cita tra i suoi libri la Bibbia perché non è un libro, è la Scrittura di Dio, da
intendersi alla lettera.
Vico era il provinciale
sublime, con una vocazione ostinata che cerca e trova la via di Damasco, la
folgorazione da dire a tutti, all'amico colto, al barbiere, alla moglie
analfabeta, per affidarla infine al proprio libro unico. Il problema del Vico
era quello delle origini. Era l'etimologista grande che cercava negli antichi
testi e nelle antiche lingue le orme dei progenitori. Purtroppo non disponeva
che della Bibbia e del latino, la sola lingua che conoscesse bene. Fece ricerche
interessanti sull'antico diritto, nel trattato De antiquissima italorum
sapientia (1710). Ma bisognava andare più in là, frugando nelle miniere del
Vecchio Testamento e di Omero.
Omero lo inquietava: possibile che in tempi così antichi esistesse già quella
"sapienza riposta" che ci vedeva il suo Platone? E tanti altri con lui? "Da
quale scuola apprese Omero tanta arte?", si chiede nella prima stesura.

Ma
intanto trovò il suo uomo di Neanderthal: i Giganti, attestati chiaramente nella
Bibbia e confermati da molte tradizioni classiche. Non si sottovaluti la
scoperta. Come avvennero? Perché?
Vico aveva lo schema della storia del genere umano nella Bibbia: sommando le
lunghissime vite dei patriarchi, si arriva alla creazione di Adamo nel 2443 a.C.;
poi gli uomini si moltiplicarono fino al Diluvio che azzerò tutto, 1656 anni
dopo, cioè nel 787 a.C. Si salvarono Noè e i tre figli Sem, Cam e Japhet; i
discendenti del primo, cioè gli ebrei, serbarono la Scrittura e la tradizione;
ma gli altri, rifugiati sulle montagne, perdettero ogni memoria della civiltà
patriarcale e precipitarono nella più orrida barbarie. Gl'infanti, abbandonati
dalle madri ferine, si rotolavano nelle loro feci; così, per effetto dei "sali
nitri", crebbero oltre misura.
Orrendi "bestioni", veri "Polifemi",
si aggiravano per la gran selva della terra, senza società e linguaggio, muti (mythus
infatti è connesso con mutus).
Per farli diventare umani e un po' più bassi non occorreva meno dell'aiuto della
Provvidenza.
Allora immaginarono mitologie naturalistiche, forgiarono le loro lingue con
radici imitative e puerili metafore, cominciarono a esprimersi col canto e, solo
più tardi, col verso (degnità LXII). Così, con "la pulizia dei corpi e
col timore degli Dei" (infatti politeia, la vita associata, è connessa
con polire e la pulizia) la statura si normalizzò.
Nacque un'umanità guerriera
e selvaggia, dotata di "una corpolentissima fantasia".
Fu l'età degli Eroi, di Achille e di Aiace, che dominavano torme di schiavi
("famuli") e comunicavano tra loro in esametri; così trasmisero le loro
conoscenze ed esperienze in una forma indifferenziata che comprendeva teologia,
storia e scienza. (Quelle, s'intende, di questa civiltà).
Immenso patrimonio orale che poi venne raccolto in due poemi (a cui si
associarono anche altri perduti) attribuiti a un immaginario Omero, che secondo
una delle più atroci etimologie vichiane significherebbe il raccoglitore (da
omoû eirein). La "corpolentissima fantasia" diede a quel linguaggio e a quei
racconti tanta efficacia espressiva. Tutto il popolo greco compose e cantò i
suoi poemi.
Perché, nella seconda
edizione, Vico si è finalmente tolto la spina, l'aporia della "sapienza
riposta". Altro che sapienza! Pura barbarie, truculenti costumi, brutali
rapporti. Alla eliminazione d'un Omero evoluto e civile hanno contribuito due
nozioni finora trascurate dal filosofo, quella di Giuseppe Flavio, secondo cui i
greci non conoscevano la scrittura quando gli ebrei avevano già un Mosè, e
quella ciceroniana secondo cui Pisistrato raccolse sparsi scritti omerici.
Non hanno valore, s'intende: Giuseppe parla ab irato di quello che
nessuno sapeva, rispondendo al greco Apione, denigratore degli ebrei, e Mosè non
è mai esistito come autore. L'altra si riferisce a un'edizione di testi che,
come tutti i libri manoscritti di tutti i tempi, circolavano in fascicoli.
Oggi sappiamo che la scrittura è molto più antica dell'ottavo secolo, ma anche
allora il semplice buon senso suggeriva che la miglior prova della scrittura è
data dalla presenza stessa di quei poemi che non si potevano affidare alla
memoria, sia per quantità che per qualità.
Dopo un'età che si potrebbe
dire di Esopo, voce dei "famuli" (Vico prende alla lettera la Vita planudea
e certi versi di Fedro), in cui nacque per i rapporti umani se non la prosa, un
ritmo più "prosastico" come è il giambo, cominciò il tempo della ragione.
Anch'essa crebbe fino ai massimi fastigi, ma non è chiaro quando ricadde,
"ri-corse", nella barbarie. Vico parla d'un periodo felice in cui sovrani
cristiani difesero la Croce, ma presto si ripiombò nell'epoca "degli Dei" (Dio e
i santi?), del mutismo, della gesticolazione, dei bestioni (non pare però
giganteschi, i "sali nitri" questa volta non agirono).
Allora (scrive Vico all'allievo Degli Angioli), "gli uomini dovevano menar la
vita nelle selve o nelle città come selve, nulla o poco tra loro e non
altrimenti che per le streme necessità della vita comunicando", in un caos di
linguaggi, fra tribù miste, "con germani e latini che ancora non si capivano".
Le due fasi degli Dei e degli Eroi non sono chiaramente distinte, ma si va
almeno dal nono secolo al dodicesimo. Quindi venne il nuovo Omero, Dante,
altrettanto barbaro e altrettanto poeta.

Leggendo
questa lettera senza venerazioni ma con la simpatia che aiuta a capire, si sente
che Vico percepisce il genio di Dante e di Omero, e anche del teatro
elisabettiano ("come oggi gl'inghilesi, poco ammolliti dalla dilicatezza del
secolo, non si dilettano di tragedie se non abbiano dell'atroce"), come qualcosa
di esplosivo, di prorompente, di irriflesso, di vergine: una forza della natura,
diremmo noi. E questo lo affascina.
Si capisce che il minuetto metastasiano gli pare poca cosa; raffinato ma povero,
sorvegliato, non fantastico. Se c'è del romanticismo potenziale in Vico è in
questa fascinazione oscura per la poesia selvaggia. E faceva i suoi poeti ancora
più selvaggi. Addirittura assenti di raziocinio, di pensiero, di civiltà:
fanciulli disumani e insensibili; non il bambino che si abbandona alle fiabe, ma
quello che tortura gli animali.
Ovviamente anche privi di ironia e senso della relatività, perché di queste era
privo anche Vico.

Certo
Vico è il primo che si pose il problema della storia, creazione umana e non
divina come la natura (che perciò è sempre inconoscibile). Ma è storia la sua o
mitologia? Se i "bestioni" anticipano, volendo, il pithecanthropus erectus,
le epoche di barbarie sono state ben diverse e non sono periodiche.
Identificando la fantasia con lo spirito del selvaggio, non se ne fa un "momento
dello spirito", che Croce tiene bene a definire "extratemporale", ma si opera
una frattura fra le due facoltà maggiori dello spirito, scienza e poesia.
Sarebbe, e sarebbe stata anche allora, una scelta ben dura.
E' vero che al tempo di Vico Omero era meno apprezzato di Virgilio, e magari di
Petrarca, e che nessun Romanticismo aveva ancora rivendicato all'arte tutta la
sua grandezza, ma nessuno, e meno che mai un romantico, avrebbe pagato la
rinascita di Omero e di Dante a prezzo della sua civiltà, modernità, anche
razionalità.
Fortunatamente la teoria di Vico sbagliò. Se i suoi tempi erano, come credeva,
al vertice dell'incivilimento, era imminente un altro precipizio; al contrario,
ragione e fantasia, scienza e poesia cresceranno insieme per secoli,
raggiungendo vette mai viste. Altro che corsi e ricorsi! Tutto è nuovo e uguale,
nel mondo. Se Vico fosse stato davvero il filosofo della storia, ci avrebbe
detto che la storia non si ripete mai, e che una filosofia della storia non c'è,
tutt'al più può esserci il contrario.

Si
dice che non bisogna tener conto delle "parti caduche" del sistema. Ma non si
può separare questa concezione dai concetti che ne scaturiscono.
La parola "fantasia" è equivoca. Quella dell'infanzia per esempio non è
fantasia, è immaginazione, inesperienza, sostanzialmente realismo. L'infante
crede alla Befana ma il poeta è l'infante cresciuto che non crede più alla
Befana. Il Märchen romantico è scettico; lirico, a volte ironico,
commosso, felice di fantasia, ma scettico sulle fate e sui coboldi e, nel caso
di Omero, su Polifemo e perfino Achille e Ulisse. Li amava, li rappresentava, ma
non ne sapeva molto più di noi.
In realtà le età "raffinate" hanno poesia raffinata e le età primitive poesia
primitiva; ma non disumana ed equivoca. Perché non sarebbe che un equivoco
scambiare per poesia la storia e la teologia, anche se è vero che Omero credeva
nel divino e pensava sostanzialmente veridica la tradizione.
Lo credeva tanto da rendercela concreta ed evidente.
A seguire passo passo, a
lettura distesa l'Iliade, finite per sentire l'odore del bronzo.
Quella tremenda lotta per la palizzata, com'è militare! E quella logica
fantastica, quel ritmo che fa tornare Achille al momento giusto! Tutto avviene
al momento giusto. E vi sono motivi sotterranei, quasi inconsci, impossibili
senza l'unità dell'opera e del genio.
Basta poco a un capolavoro: un'idea - Achille che non ammette la vita se non
immortale, perché è semidivino, e preferisce la morte a una vita lunga e bella,
perché per lui la vita è sempre breve, indegna di durare -, un disegno, un
fatto, uomini, i grandi motivi della vita: l'odio, l'ira, la rivalità,
soprattutto la morte.
C'è perfino una struttura del poema che non sarebbe difficile descrivere,
fondata su ogdoadi e tetraodi.
Omero è più diamantino di Dante, dove sarebbe più facile trovare incongruenze.
Per dirne una sola, Bonifacio nel canto XIX dell'Inferno è dannato e nel
XX del Purgatorio è venerato. Forse il primo rapsodo è ghibellino e
l'altro è guelfo? Tra Inferno e Paradiso, anche linguisticamente,
non passa meno distanza che tra l'Iliade e l'Odissea, scritta
secondo Vico dopo molte generazioni.
E la frantumazione della
Commedia che cosa sarebbe prima di tutto, se non la distruzione del suo
valore poetico? Ci perderemmo a cercare e ricomporre, senza costrutto, i
frammenti. E' perciò una curiosa pretesa quella di Vico di esaltare Omero
distruggendone l'unità (che avrebbe detto il suo Orazio?).
Non è necessario, per
elogiare Vico, vituperare il secolo prosaico, che non fu poi solo tale. Anzi
sarebbe stato forse più facile far riflettere Cartesio sui problemi della storia
e dell'estetica che a Vico acquisire un po' del rasserenante buon senso di
Cartesio, oltre a tutto ottimo scrittore.

G. Vico, Opere
filosofiche, a cura di: Badaloni e P. Cristofolini, Firenze 1971,
p. 455 e altrove.
Ibid. p. 475.
Ibid. p.476.
Pubblicato in «La Nuova Tribuna
Letteraria», anno XV, n. 78, 2005, pagg. 9-11 |

